Tutti sanno che è Rossi il cognome italiano più diffuso, al punto da identificare l’italiano medio proprio nel signor Rossi. L’origine del cognome, ben distribuito in tutta la penisola e corroborato anche da varianti regionali come i Lorusso e i Larussa in Sicilia e i Russo nel meridione d’Italia in genere, è legata alla colorazione dei capelli o della carnagione dei capostipiti. Non tutti però riflettono sul fatto che tali caratteristiche fisiche evidenti al primo colpo d’occhio erano minoritarie o addirittura rare in un contesto peninsulare, dove nei secoli scorsi a predominare incontrastati erano la carnagione e i capelli neri o bruni.
La rarità, congiunta ai pregiudizi sui diversi, portava ad etichettare in maniera automatica le persone dalla pelle e i capelli rossi con il soprannome di rosso o rossa, e rossi i loro familiari. Quando poi, nel corso del Cinque e del Seicento, si è andato formalizzando il cognome, il travaso nei cognomi dei soprannomi in uso ha fatto registrare il cognome Rossi e varianti in ogni comunità, per grande o piccola che fosse, al punto da far derivare da una caratteristica fisica rara il cognome più diffuso nella penisola. Dalla rarità alla profusione. Dallo stigma del diverso a quello opposto del banalmente comune.
Si diceva dei pregiudizi popolari che marchiavano il rosso (e la rossa). Basta citare i proverbi molisani che lo dipingono maligno, U rusce malepjnte (malupine a Napoli, malpelo in italiano), dalle pessime abitudini, Rusce de vjse e de custume, e dal carattere indecifrabile U rusce annanze te mure e nno ca u canusce (fai prima a morire che a conoscerlo). Li compendia tutti la bruttissima fine fatta fare alla madre dal migliore dei suoi sette figli rossi, ricordata in un proverbio dal tono addirittura epico: ‘A mamme tenéve sette figlie rusce, u cchiù bbune ‘a jettatte da fenestre (o nu puzze).
Questi pregiudizi li ho vissuti sulla mia pelle rossa durante l’infanzia e l’adolescenza in paese, nei lontani anni Sessanta del secolo scorso, quando qualsiasi battibecco con i compagni di gioco sfociava in un coro di scherno: U rusce, u rusce! Non avevano bisogno di aggiungere altro. Bastava che sottolineassero quel tratto distintivo. E se proprio volevano infierire, insistere con U pile rusce!
Ovviamente ero u rusce anche per gli adulti, i quali, senza intenzioni malevole, finirono per sbattezzarmi. Spesso mi sentivo chiamare Nicola, perché Nicola si chiamava uno dei tre figli rossi di Cola Giacinte. Confondendomi con quel ragazzo, mi includevano nel suo nucleo familiare.
Questo perché nella mia famiglia, a parte la nonna morta prima che io nascessi, di pelo rosso viventi c’ero solo io. Non era sopravvissuto nessuno dei suoi venti fratellastri, tutti rossi e tutti morti alla nascita o pochi giorni o settimane dopo, tanto da suggerire al medico condotto un estremo tentativo. Convocate la povera madre e la cognata, che si erano ritrovate incinte in contemporanea, le invitò a provare a scambiare i nascituri, allattando l’una il figlio dell’altra. Niente da fare. Benché allattato dalla cognata, neppure il ventunesimo neonato dai capelli rossi sopravvisse. Sopravvisse, invece, mia nonna, rossiccia a sua volta, che allattata dalla zia fu da costei trattenuta in casa e allevata come la figlia che non aveva mai avuto e che adesso finalmente aveva.
Tornando ai tormenti infantili, in quegli anni imperversava Renato Carosone, anche con la canzone di O russe e ‘a rosse. E così uscendo in strada, non era raro dover sorbire l’esuberanza canterina, con annessi commenti e battutine, di chi attaccava il ritornello, almeno per me ossessionante, di “O russe quanne vede ‘a rosse le vene ‘a tosse”.
Per fortuna, a scuola andavo bene, tanto da meritare la considerazione dei compagni di classe, di uno di loro in particolare, al quale piacque tradurre rusce o meglio ancora pile rusce in Capelli d’oro. Così mi chiamò Capelli d’oro per qualche tempo. E con il nome di Capelli d’oro mi indicò, durante le vacanze, ai compagni che, dopo il bagno, stavano prendendo il sole sulla spiaggetta della Chiata Senzasangue, quando s’accorse che stavo annaspando in quello specchio d’acqua del Tappino, neppure tanto profondo, dove ero rimasto a sguazzare da solo nel tentativo di imparare a nuotare.
– Ohò… Capelli d’oro! Mi sembra ancora di risentire l’urlo, lo scalpiccio precipitoso e lo scroscio provocato da una schiera di ragazzi, che mi spinsero di peso, verso la riva opposta, in salvo.
Senza ulteriori traumi, passarono gli anni delle scuole medie a Campobasso. Anzi, i nuovi compagni non fecero neppure tanto caso al colore dei miei capelli. Neppure dopo la lettura di Rosso malpelo la novella di Verga che rimanda a un mondo siciliano, avvertito lontano dal nostro mondo d’allora, che pure era tutt’altro che florido ed evoluto. Né ci coinvolse più di tanto la storia di quell’adolescente dai capelli rossi, emarginato e vittima dei pregiudizi popolari, condannato a un duro lavoro nelle cave di rena, nella realtà siciliana di fine Ottocento di miseria e sfruttamento, e quindi alla tragica fine, analoga a quella del padre.
Ci fu un ritorno di fiamma nel primo superiore, quando mi ritrovai bersaglio di due ragazzotti pluriripetenti che dall’alto della loro boria di diciassette, diciottenni campobassani veraci credevano di spassarsela ai danni del rosso e smilzo quattordicenne che ero. Per diversi giorni di seguito, dovetti entrare in aula a suon di U rusce! o U ruscione! e grasse risate aggiunte. Provai a sorridere le prime volte. Poi a mostrarmi contrariato. Non ci fu niente da fare. Continuarono a martoriarmi. Né si limitarono a sbeffeggiare e a sghignazzare. Uno dei due cominciò a infierire con volgarità, tipo U rusce, ‘n cule t’u strusce.
Non ricordo se feci leva sul silenzio degli altri compagni, che interpretai di solidarietà nei miei confronti. Né se a incoraggiarmi fu la corporatura piuttosto meschina dei due ragazzotti. Fatto sta, che una mattina, non appena varcata la porta dell’aula, all’udire i soliti insulti, azzeccai il mento di uno dei due con un pugno. Ne rimasi sbalordito. Aveva fatto ricorso alle mani per la prima volta (e l’ultima). Sbalordito e pronto a subire una replica fatta di calci e pugni e sopraggiunta di offese. Ma non ci fu nessuna replica. Massaggiandosi il mento, l’uno cominciò a piagnucolare mentre l’altro farfugliava frasi per invitarmi a calmarmi, a non prendermela, perché – diceva – stavano solo scherzando. Come me rimase sbalordita tutta la classe. Ma sbalorditi più di tutti erano rimasti i due ragazzotti. Sbalorditi e codardi.
Fu allora che, lasciato finalmente in pace, sanai i conti con il pregiudizio che per secoli aveva maltrattato i rossi e per quattordici anni me stesso. Mi auguro che nel frattempo sia stato debellato ovunque e che nessuno ne abbia più sofferto, tanto più che negli ultimi decenni i caratteri somatici degli italiani si sono fatti meno pronunciati e meno mediterranei.
In conclusione, mi veniva di riflettere come in maniera parallela, seppure a somatica invertita, il cognome Brown sia uno dei cognomi più diffusi in gran Bretagna. Si sa che brown significa marrone, anzi, in ossequio alla etimologia comune, bruno (per un convincente riscontro fonetico si provi a pronunciare bruno alla montaganese). E allora in quel mondo di biondi, con occhi e pelle chiara, ho immaginato la presenza discreta di uomini con la pelle e i capelli più scuri, fatti oggetto di attenzioni e giudizi, analoghi a quelli si riversavano sui rossi in Italia. Così, sperando prima o poi di leggere storie partorite dalle attenzioni e dai pregiudizi britannici ai danni di connazionali dai tratti mediterranei, mi è parso doveroso affiancare Mr. Brown al nostro signor Rossi in una ideale galleria di “umiliati e offesi” più o meno bonariamente, prima che di stereotipi nazionali.



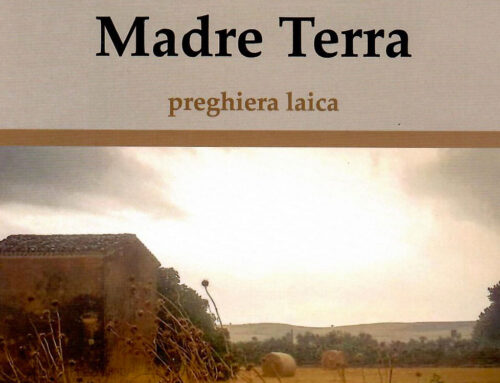




Scrivi un commento